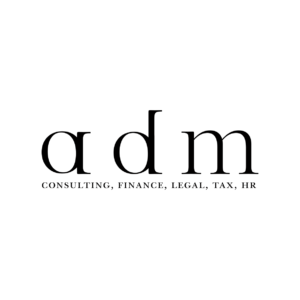Accade soventemente agli imprenditori di imbattersi in proposte di colleghi che intendono affittare il loro compendio aziendale oppure un ramo dello stesso. Si tratta di occasioni certamente appetibili soprattutto per chi vuole espandere la propria attività in maniera rapida, mirando ad acquisire velocemente un pacchetto di clienti, determinati rapporti contrattuali strategici per caratura della controparte, oggetto o luogo d’esecuzione o per acquisire nuove unità produttive già funzionanti. Uno degli schemi più utilizzati è certamente quello del contratto d’affitto d’azienda legato ad un diritto d’opzione di acquisto a favore del conduttore oppure ad un altro contratto che garantisca la futura possibilità di acquistare il compendio aziendale. Il beneficio è evidente: l’imprenditore acquirente può utilizzare e quindi testare e saggiare la “bontà” dell’azienda avendo usualmente la facoltà, e non l’obbligo, di acquistarla o meno successivamente ad un determinato prezzo. Addirittura, il potenziale acquirente può scegliere se rinunciare al diritto d’opzione, intavolando una trattativa con il proprietario per ottenere una riduzione del prezzo di vendita. Questo schema negoziale tuttavia non è “invulnerabile” alle vicende patrimoniali del proprietario dell’azienda e, in taluni casi, costituisce un importante fattore di rischio da considerare quando si valuta l’investimento. Lo scenario che si potrebbe prospettare è il seguente. A affitta a B la propria azienda stabilendo un canone di 100 all’anno per 9 anni. Viene altresì pattuito un diritto d’opzione a favore di B di acquistare il ramo d’azienda al prezzo di 1500 entro 5 anni. B entra in possesso del ramo aziendale e, grazie ai propri investimenti e capacità imprenditoriale, lo sviluppa, aumentandone il valore. Tuttavia, prima che venga esercitato il diritto d’opzione A viene dichiarato fallito dal Tribunale. La situazione di B è a questo punto critica, dato che potrebbe vedere vanificati i propri investimenti di tempo e denaro. Il primo scoglio è dettato dall’art. 79 della legge fallimentare. “Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto d’affitto d’azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall’articolo 111, n. 1.” Il dettato legislativo descrive un meccanismo che non è automatico, anzi prevede che, normalmente, il contratto d’affitto d’azienda sopravviva al fallimento. Tuttavia, dietro ad una fattispecie che appare porre sullo stesso piano parte e curatela, si nasconde una certa insidia, soprattutto nel caso in cui l’azienda condotta in affitto abbia acquistato valore grazie alla capacità imprenditoriale di B. Infatti, agli occhi degli organi del fallimento e della massa dei creditori, B conduce in affitto un’azienda ad un canone e con un potenziale prezzo di vendita minore rispetto a quello attuale. È obiettivamente loro interesse ottenere quindi un sostanziale adeguamento del canone oppure sciogliere il contratto. Con questo meccanismo è quindi B che si deve “adeguare”, probabilmente accordando un aumento del canone, dovendo di contro affrontare la possibilità, più o meno concreta rispetto alle peculiarità della singola realtà aziendale, di perdere sia la possibilità di condurre l’azienda sia, per quanto si dirà successivamente, quella di comprarla. Certo, in caso di recesso dal contratto da parte del fallimento, è previsto che B riceva in prededuzione un indennizzo ma la sua quantificazione e termine di pagamento saranno sicuramente oggetto di una dura trattattiva e, difficilmente, sarà una soluzione profittevole o remunerativa per l’imprenditore. Il secondo scenario, addirittura peggiore rispetto al precedente, è delineato invece dall’art. 67 della legge fallimentare, che disciplina l’azione revocatoria: “Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso (…)” L’esercizio dell’azione revocatoria è ancora di più deleteria del semplice recesso. B, in questo caso, si troverà a subire un’azione legale, la cui prova di non conoscenza dello stato d’insolvenza di A, è a suo carico. Una prova che in concreto sarà molto difficile da dare dato che, è giocoforza delle trattative propedeutiche all’affitto d’azienda, che B abbia visionato documenti contabili che danno concrete indicazioni sullo stato patrimoniale di A. Oggetto di aspra controversia sarà sicuramente poi anche il requisito della quantificazione del canone, ovvero se questo sia adeguato, nel limite minimo del quarto di scarto rispetto ad un valore “giusto”. Valore che è di difficile calcolo, dato che non ne esiste una definizione univoca o accettata ed anzi, che è soggetta alle più disparate interpretazioni, soprattutto con aziende che al momento della stipula del contratto presentavano un valore di avviamento negativo o comunque significativamente minore di quello attuale. Tornando alla vicenda trattata poniamo a questo punto che B riesca a trovare un accordo con la società in fallimento e che riesca superare tutti i rischi sopra descritti. L’operazione iniziale e l’interesse imprenditoriale di B sono comunque compromessi. Questo per due motivi. Il primo è dato dal fatto che l’opzione è un contratto separato ed autonomo rispetto all’affitto, anche se inserito nel medesimo documento contrattuale. Questa può essere quindi liberamente sciolta, in completa autonomia, dal curatore fallimentare. Il secondo è che l’azienda di proprietà di A dovrà essere ceduta mediante una procedura competitiva aperta al pubblico, senza che B possa opporre il suo diritto d’opzione. Fondamentalmente l’azienda verrà acquistata dal miglior offerente, mentre il prezzo d’acquisto richiesto per l’esercizio del diritto d’opzione può costituirne, tuttalpiù, la base di partenza. Dunque, in definitiva, B si troverà a condurre l’azienda, sviluppandone il valore e le potenzialità, senza avere la certezza di acquistarla ad un determinato prezzo, anzi, essendoci la concreta possibilità che il proprio lavoro di sviluppo venga acquistato da terzi senza alcuna remunerazione. Evitare queste situazioni è possibile quindi solo tramite una attenta e preventiva opera di “ingegneria giuridica” prevedendo tutti i correttivi e le tutele necessarie nel o nei contratti iniziali, volti ad evitare di trovarsi in estrema difficoltà una volta a contatto con una procedura fallimentare.
Per maggiori informazioni rivolgiti ai nostri esperti di consulenza aziendale all’indirizzo info@admassociati.it