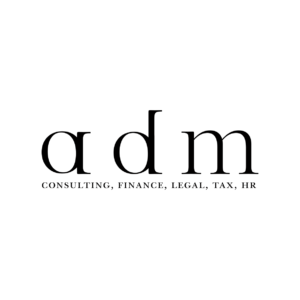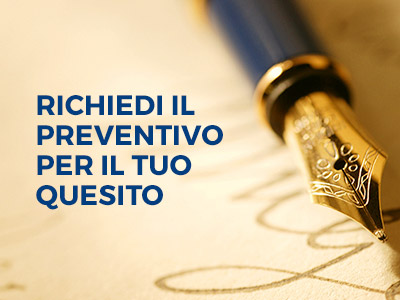L’art. 1, nota II-bis, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n.131/1986 dispone l’assoggettamento a tassazione agevolata degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e degli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse.
La fruizione del regime di favore – consistente nell’applicazione, laddove il venditore sia un privato, dell’imposta di registro con aliquota del 3% (anziché quella ordinaria del 7%) e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa – è tuttavia subordinata al ricorrere congiunto di alcune condizioni soggettive (relative all’acquirente dell’immobile) ed oggettive (attinenti alla natura e all’ubicazione dell’immobile acquistato).
Tra le condizioni oggettive spicca quella relativa al luogo in cui l’immobile acquistato deve essere ubicato, il quale può consistere:
- nel comune di residenza dell’acquirente;
- nel comune in cui l’acquirente stabilisca, entro diciotto mesi dall’acquisto, la propria residenza;
- se diverso dal comune di residenza, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività,
A riguardo precisiamo che le agevolazioni fiscali “prima casa” non richiedono il posizionamento della residenza nell’abitazione acquistata, ma nel territorio Comune ove essa è ubicata.
Pertanto, ai fini del godimento delle agevolazioni “prima casa”, è necessario e sufficiente che l’immobile acquistato sia ubicato nello stesso Comune in cui l’acquirente ha la residenza: a nulla rileva il fatto che la residenza coincida con l’immobile indicato nell’atto di acquisto.
Venendo al caso in questione, dato che la proprietà dell’immobile è divisa a metà tra il Sig. XXXXX e la sua fidanzata, per uno dei due soggetti (il Sig. XXXXX) il problema non persiste essendo egli stesso residente nel Comune in cui l’immobile acquistato è ubicato, mentre per l’altro soggetto, non essendo lei stessa residente in tale Comune, avrà diciotto mesi di tempo dalla data di stipula dell’atto notarile per trasferirvi la residenza. Se, ad esempio, l’atto è stato stipulato in data 29.11.2011, il soggetto non residente avrà tempo sino al 29.05.2013 per effettuare il cambio di residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato.
Rimane, poi, da affrontare la questione riguardante la detrazione degli interessi passivi sui mutui accesi per la costruzione e/o ristrutturazione di un immobile da adibire ad abitazione principale.
A riguardo, l’art. 15, comma 1-ter del TUIR (D.P.R. n.917/1986) prevede per i soggetti IRPEF (come le persone fisiche) la possibilità di detrarsi dall’imposta lorda una quota pari al 19% degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
L’importo massimo della detrazione deve essere commisurato in base al rapporto tra la somma effettivamente sostenuta (e documentata) per la costruzione dell’abitazione principale e il capitale preso a mutuo, di modo che la quota di interessi da portare in detrazione sia rapportata a quella relativa alla parte di mutuo effettivamente utilizzata per tale operazione. L’importo massimo della detrazione non può comunque superare complessivamente gli Euro 2.582,28.
A riguardo, la circolare n.17/E del 03.05.2005 ha ribadito che la somma delle spese effettivamente sostenute è “quella che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell’unità immobiliare”.
Pertanto, nel caso di lavori di ristrutturazione o costruzione di durata superiore all’anno è ammessa la possibilità di operare la detrazione degli interessi passivi corrisposti nella maniera che segue:
- nei periodi di imposta nel corso dei quali risultano ancora in essere i lavori, il contribuente può fruire della detrazione sul 100% degli interessi passivi corrisposti, senza operare alcun rapporto rispetto alle spese sostenute, il cui importo non risulta ancora definitivo;
- a decorrere dal periodo di imposta nel quale risultano terminati i lavori, essendo il contribuente in possesso di tutte le fatture comprovanti le spese sostenute negli anni, va effettuato il rapporto di verifica dell’effettiva detraibilità (somma delle spese sostenute/capitale preso a mutuo).
Nel caso in cui dal rapporto sopra citato risulti una percentuale di detraibilità effettiva inferiore al 100%, il contribuente deve provvedere a rettificare le precedenti dichiarazioni nelle quali è stato indicato un ammontare di interessi passivi superiore a quello effettivamente detraibile.
Precisiamo, inoltre, che nel caso di più intestatari del contratto di mutuo, ogni contitolare può portare in detrazione la propria quota di interessi, in relazione alla propria quota di spettanza. Viceversa, se l’acquisto dell’immobile avviene in comproprietà, ma solo uno dei soggetti stipula il contratto di mutuo, quest’ultimo può beneficiare della detrazione al 100% (naturalmente, in relazione al rapporto tra le spese effettivamente sostenute ed il capitale preso a mutuo, come specificato qui sopra).
La norma del TUIR, e il DM n.311/1999 stabiliscono alcune condizioni da rispettare affinché gli interessi passivi possano essere detratti dall’imposta IRPEF lorda.
La prima condizione consiste nell’adibire l’immobile ad abitazione principale entro e non oltre sei mesi dal termine dei lavori di costruzione.
Una definizione di abitazione principale è rintracciabile nell’art. 10 del TUIR in cui si precisa che per abitazione principale deve intendersi “quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.” Con l’espressione “familiari” il legislatore fa riferimento al coniuge, anche separato (ma non divorziato), ai parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado.
La nozione di abitazione principale contiene in sé il concetto di unicità, pertanto non si possono avere più abitazioni principali. Inoltre, tale nozione deve essere sempre riferita a colui che espone le detrazioni degli interessi passivi nella propria dichiarazione dei redditi.
Per altro verso, la nozione di “abitazione principale” deve essere distinta da quella di “prima casa”. I due termini sono spesso usati come equivalenti, pur avendo significati molto diversi, e dando luogo ad agevolazioni fiscali differenti. Con il termine “prima casa” s’intende l’immobile acquistato come prima abitazione con le relative agevolazioni previste in materia I.V.A. o di imposta di registro. Per “abitazione principale”, invece, s’intende l’immobile adibito a dimora abituale indipendentemente dal fatto che sia o meno la prima casa acquistata. Le due nozioni possono coincidere, come nel caso in cui si abita nella prima casa acquistata, ma se l’abitazione principale è stabilita in una seconda o in una terza casa acquistata o, addirittura, in un immobile preso in affitto, i due termini non coincidono. Pertanto, ai fini del riconoscimento delle detrazioni in argomento, è necessario specificare che l’immobile è adibito ad abitazione principale a prescindere che si tratti o meno di una prima casa.
L’altra condizione da rispettare, oltre a quella analizzata, è:
- la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio del lavori di costruzione.
Viceversa, si decade dai benefici di cui sopra se:
- una delle condizioni sopra descritte non viene rispettata;
- se i lavori di costruzione dell’abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dalle autorizzazioni edilizie, fatta salva la possibilità di proroga delle stesse.
Qualora, successivamente, il contribuente nono utilizzi più l’immobile quale abitazione principale, decadrà dal beneficio a partire dal periodo di imposta successivo.
Non si ha, invece, decadenza dal beneficio, se il ritardo nella conclusione dei lavori è imputabile esclusivamente all’Amministrazione per il rilascio delle abilitazioni richieste per la costruzione o la ristrutturazione.
In ultima, per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere a richiesta dell’Amministrazione:
- la copia del contratto di mutuo dal quale risulti il rilascio della garanzia ipotecaria e che il finanziamento è stato concesso per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale;
- le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia;
- le copie dei documenti comprovanti le spese di costruzione dell’immobile (fatture, ricevute fiscali).
Per quanto riguarda la sussistenza del requisito di abitazione principale è data la possibilità di dimostrare l’utilizzo dell’immobile quale abitazione principale anche attraverso l’autocertificazione e non solamente per mezzo delle risultanze dei registri anagrafici.
Illustrata la disciplina sulla detrazione degli interessi passivi ai fini IRPEF sui mutui contratti per la costruzione dell’abitazione principale, facciamo alcune considerazioni finali sul caso prospettato:
- dato che il mutuo ipotecario è stato stipulato in data 17/05/2012 e che l’inizio dei lavori è avvenuto il giorno 26/03/2012, una delle condizioni risulta soddisfatta.
- non risulta però soddisfatta, per l’anno 2012, la condizione circa la destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, posto che alla data del quesito si è avuta solo la demolizione delle porzioni di fabbricato insistenti alla data dell’acquisto e oggetto della transazione. Ne consegue che in Unico 2013 per l’anno 2012 non sarà possibile, per nessuno dei due contitolari del contratto di mutuo, portarsi in detrazione gli interessi passivi pagati.
- bisognerà verificare che i lavori di costruzione dell’abitazione principale vengano ultimati entro il termine previsto dalle autorizzazioni edilizie, fatta salva la possibilità di proroga delle stesse, pena la decadenza dal beneficio.
Infine, merita un accenno la questione circa la possibilità o meno di fruire della detrazione dall’imposta lorda IRPEF di un importo pari al 36% delle spese documentate sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previsto dall’art. 16-bis del TUIR.
A riguardo, in più occasioni l’Amministrazione finanziaria ha precisato che nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e costruzione, la detrazione compete solamente in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente, mentre nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione da cui ne derivi un edificio nel suo complesso diverso, per sagome e volumi, da quello originario, si configura un “intervento di nuova costruzione”, non agevolabile fiscalmente dalla norma sopra richiamata.
Con riferimento al caso in questione, stante i documenti e le informazioni fornite, si ritiene che l’agevolazione fiscale del 36% non sia applicabile in quanto si ricade nella fattispecie di “nuova costruzione”, essendo l’edificio in costruzione sostanzialmente diverso per sagoma e volumetrie da quello originario e demolito.